(s.m — neologismo), può significare:
- produzione letteraria o televisiva finalizzata al puro intrattenimento;
- divertissement, composizione letteraria o artistica di tono leggero che nasce come divertimento dell’autore;[1]
- localismo tipicamente pugliese–salentino che si riferisce alle feste estive di piazza, di spiaggia o in discoteca e alla miscellanea di brani e generi musicali generalmente ballati in tali occasioni. La “musica da divertentismo” include solitamente brani attinti soprattutto dai repertori del revival dance–pop, latin–pop, euro house, disco music e musica italiana di vari generi dagli anni 1970 in poi. La selezione musicale del “divertentismo” deve tenere conto dei gusti di un pubblico occasionale, vario, trasversale e in genere poco esigente dal punto di vista musicale: sono preferiti quindi brani ritmati, scanzonati, melodicamente semplici, molto conosciuti e ben collaudati.
Il termine, formato dall’aggettivo divertente unito al suffisso –ismo che caratterizza vocaboli astratti relativi a tendenze o movimenti (suffisso diffusosi principalmente tra Ottocento e Novecento), è utilizzato almeno dalla seconda metà del 20° secolo in riferimento ai prodotti letterari (“divertentismo letterario”), ma anche televisivi, orientati al puro intrattenimento:
…nel bene, poiché essa [la trasmissione televisiva, n.d.a.] avrebbe maggior possibilità di approccio informativo proprio là dove se ne sente maggiormente la richiesta, come nel male, poiché gli effetti più tangibili sarebbero il divertentismo e l’assenza di critica.
Comunità — Giornale mensile di politica e cultura,[2] 1966. 136–140 pag. 114
Siamo all’insegna di un divertentismo scapigliato, ma le intuizioni felici non mancano davvero: o che si dia addosso al Pascoli, con effetti di spasso irresistibile, o che si metta in rilievo estrosamente la genialità di D’Annunzio.
Vittorio Spinazzola, Dopo l’avanguardia, 1989. Pag. 107.
Il divertentismo da ballare

Maurizio Canepa in trasmissione a Ciccio Riccio tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90.
In ambito musicale, il termine fu “reinventato” nel 1990 da Maurizio Canepa, allora speaker presso l’emittente radiofonica pugliese Ciccio Riccio di Brindisi. La radio nacque all’inizio degli anni ’80 da un’idea di Mino Molfetta e, per far fronte alle crescenti richieste dei locali, fu affiancata da un’agenzia di spettacolo seguita da Sandro Toffi, che si occupava di gestire gli ingaggi degli artisti. Racconta lo stesso Maurizio Canepa: «In questo periodo suonavamo principalmente musica new wave; Sandro ebbe l’intuizione di inserire all’interno delle serate più commerciali una parte dedicata alla musica più conosciuta ed allegra: un momento di completo divertimento e spensieratezza». Rispetto alla cosidetta “happy music” proposta da altri locali, la scaletta ideata da Sandro Toffi introduceva vari generi musicali come il rock e la disco degli anni ’70, la musica italiana degli anni ’60, fino alle sigle dei cartoons. Altra caratteristica fondamentale era l’idea di proporre una sequenza velocissima, con mixaggi rapidi e cambi di brano dopo circa un minuto o meno, riprendendo così lo stile medley degli anni ’70. Durante i programmi radiofonici gli speaker pubblicizzavano le serate, e sorse così la necessità di dare un nome a questo format distintivo che non aveva alcuna connotazione né denominazione.
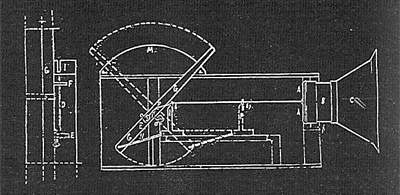
Un “intonarumori”, strumento inventato dal futurista Luigi Russolo nel 1913.
L’idea fu di Maurizio Canepa, che in quel periodo si era recato a Roma e aveva visitato una mostra sul futurismo: «mi impressionò molto quel fenomeno culturale, in particolare la sezione dedicata agli “intonarumori”, invenzioni stranissime (delle scatole con delle manovelle che girate manualmente producevano vari rumori). Quando rientrai a Brindisi, durante il solito programma del sabato pomeriggio, come sempre dovevo pubblicizzare le varie tappe nei locali della Puglia, e mi venne in mente la parola “divertentismo”, si adattava benissimo per definire il format che Sandro aveva ideato: un momento dedicato al divertimento puro senza nessun legame logico con il genere new wave o disco, solo divertimento attraverso musica molto conosciuta, divertente e mixata in modo veloce. Sia a Sandro che agli altri il termine piacque molto tanto da essere utilizzato costantemente sia per radio che sui volantini locandine ed inviti.»
Il termine divertentismo, nell’ambito dei locali da ballo, nacque quindi dalla parola futurismo: come questa designava un movimento dedicato alla passione per la modernità ed il futuro, «divertentismo invece doveva definire un momento dedicato al divertimento puro, un movimento dedito al divertimento (anche se solo per un oretta in discoteca)!»
Tanto il format di Toffi quanto il termine reinventato da Canepa ebbero una immediata diffusione: «In men che non si dica divenne di dominio pubblico, non solo noi ma anche altri locali, emittenti radiofoniche e televisive iniziarono a definire momenti divertenti nello stesso modo, ovunque si ballasse musica divertente veniva utilizzato il termine “divertentismo”.»
Lo stesso Canepa è sorpreso della longevità e della diffusione del termine: «Ormai vivo lontano dalla Puglia. Lo scorso anno [2016, n.d.a.] durante una vacanza in un villaggio del Salento, uno degli animatori, per pubblicizzare la serata utilizzò questa terminologia, un ragazzino del nord Italia. Questa cosa mi colpì molto, dopo tanti anni ancora si utilizzava questa parola. Così ho iniziato a fare delle ricerche su internet e mi sono reso conto che ormai c’è di tutto, pagine facebook, Spotify, siti internet, se ne parla nei blog, sui giornali…»
Da occasionalismo (nonce word) destinato al lessico dei locali da ballo, era entrato nel linguaggio corrente. Dato per morente da Repubblica nel 2003 (“Estate, il Salento vince ancora”, 31 agosto 2003 ), è registrato invece come vivo e vegeto in Puglia nel 2005 dalla rubrica “Avanti Pop” di Maria Laura Rodotà su Corriere.it, non solo nella lingua parlata ma anche nella scrittura effimera della pubblicità locale: «questa parola compariva sui volantini delle discoteche, ma anche sulla bocca della gente!»
Per estensione, il termine ha assunto anche l’accezione dispregiativa di divertimento nazionalpopolare, forzato ed artificioso:
…un odioso momento di divertentismo dozzinale, buono per le orecchie poco raffinate di quel grumo di trentacinquenni ormai troppo avvezzi a partecipare a feste di matrimonio, con la loro forma di svago preconfezionato, sempre uguale a se stesso, condito da frasi imbarazzanti dello speaker che cerca di riempire con formule ridicole il vuoto della sua selezione musicale.
Manlio Ranieri, La Nera (Musicaos, 2015)
- [1]Es. «in appendice un divertentismo a cura di Antonella Gaeta» (da Figli di B: a una voce per il teatro a cura di C. Coppola, FAL Vision 2013).↩
- [2]Fondato dall’imprenditore progressista Adriano Olivetti nel 1946, e da lui diretto sino alla sua morte nel 1960. La rivista era legata a “Movimento Comunità”, partito politico socialista e liberal–democratico nato in Piemonte nel 1947 come movimento culturale, e trasformato in organizzazione politica dallo stesso Olivetti.↩
- Colucci, Michele “Ismi e istiche — Glossario esterofilo” in Oblomov Press, 12 Dic. 2014.
- “Divertentismo??” in “Avanti Pop” da Corriere.it, 10 Ott. 2005.
- Si ringrazia il sig. Maurizio Canepa.
Foto: festa di matrimonio nel Galles, Mitchell Orr/Unsplash




